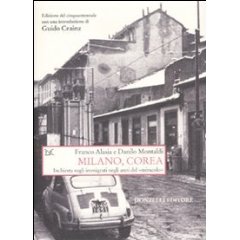 Come ogni classico, Milano, Corea di Franco Alasia e Danilo Montaldi (Donzelli 2010, pp. 335, E. 28, nota introduttiva di Guido Crainz) si apre a tantissime letture – in termini (anche attualizzanti) di storia delle migrazioni, di storia della sociologia e delle scienze sociali, di storia urbana, storia del lavoro… A me, che lo leggo a cinquant’anni dalla sua prima pubblicazione, fa effetto soprattutto il modo in cui è stato prodotto. C’è un’espressione americana – leg work, lavoro di gambe – che descrive la fatica fisica e la minuziosa osservazione in cui consiste quello che si suole chiamare “lavoro sul campo”. Alasia e Montaldi hanno lavorato di gambe per fare questo libro: andando a cercare le fonti nelle periferie, nei comuni del circondario, nelle “coree”, gli agglomerati spontanei generati (come i borghetti dei baraccati a Roma) dalla modernità e dalle ingiustizie del “miracolo italiano”, facendo il “giro di Milano” per andare a vedere le facce e i vestiti di chi stava seduto sulle panche in attesa di una minestra in parrocchia, per rendersi conto dei complicati percorsi quotidiani di chi metteva insieme una vita dai frammenti dell’esclusione e della marginalizzazione, costruendosi la casa letteralmente con le macerie recuperate e con gli avanzi dei cantieri.
Come ogni classico, Milano, Corea di Franco Alasia e Danilo Montaldi (Donzelli 2010, pp. 335, E. 28, nota introduttiva di Guido Crainz) si apre a tantissime letture – in termini (anche attualizzanti) di storia delle migrazioni, di storia della sociologia e delle scienze sociali, di storia urbana, storia del lavoro… A me, che lo leggo a cinquant’anni dalla sua prima pubblicazione, fa effetto soprattutto il modo in cui è stato prodotto. C’è un’espressione americana – leg work, lavoro di gambe – che descrive la fatica fisica e la minuziosa osservazione in cui consiste quello che si suole chiamare “lavoro sul campo”. Alasia e Montaldi hanno lavorato di gambe per fare questo libro: andando a cercare le fonti nelle periferie, nei comuni del circondario, nelle “coree”, gli agglomerati spontanei generati (come i borghetti dei baraccati a Roma) dalla modernità e dalle ingiustizie del “miracolo italiano”, facendo il “giro di Milano” per andare a vedere le facce e i vestiti di chi stava seduto sulle panche in attesa di una minestra in parrocchia, per rendersi conto dei complicati percorsi quotidiani di chi metteva insieme una vita dai frammenti dell’esclusione e della marginalizzazione, costruendosi la casa letteralmente con le macerie recuperate e con gli avanzi dei cantieri.Lavoro di gambe significa camminare, e quindi guardare il mondo dal livello della strada (del prato, del vicolo, del fosso, del parco notturno, del pavimento mezzo finito della casa auto costruita) – non tanto “dal basso” quanto orizzontalmente. Mettersi al livello della strada è un modo di viaggiare vedendo i dettagli che sfuggono allo sguardo egemonico dall’alto; ed è anche un significativo gesto di umiltà: vuol dire rinunciare all’arroganza implicita nel ruolo di “osservatore” in relazione reificante con l’”osservato”, e disporsi invece a un ascolto, a un apprendimento che deriva dell’incontro fra persone che si guardano fra loro (intervista infine significa questo). Che questo, infine, è il principio di ogni ricerca sul campo: un progetto di incontro, un riconoscimento di non sapere, uno sguardo su quello che non si vede.
L’Italia del miracolo economico è piena di luoghi e persone non visti: la “corea” milanese di Alasia e Montaldi è il corrispettivo settentrionale della “terra del rimorso” e delle “indie di quaggiù” di Ernesto De Martino e della Partinico siciliana di Danilo Dolci. Per questo, gli strumenti della sociologia convenzionale, specie nella versione positivista parsonsiana allora dominante ma anche nel progressismo tecnocratico con cui Montaldi polemizza tutta la vita, sono inadeguati alla conoscenza di queste realtà. Ci vuole qualcosa di più aperto, qualcosa in cui l’agenda delle domande e dei problemi non sia posta a priori ma sia derivata dall’osservazione e dall’ascolto senza preconcetti. Così, Alasia e Montaldi sono fra i fondatori di quella ristretta schiera di ricercatori, tutti fuori dell’accademia e ai margini della politica ufficiale, che usano in primo luogo le storie – biografie, storie di vita, ma anche semplicemente racconti: Danilo Dolci, appunto (di cui Alasia fu allievo e collaboratore), Rocco Scotellaro, il Goffredo Fofi dell’Immigrazione meridionale a Torino, e io ci metterei anche Gianni Bosio. E non è un caso se, come fa notare Guido Crainz nell’introduzione a questa nuova edizione, quegli anni sono stati raccontati soprattutto dal cinema e dalla letteratura.
Credo che sia stato Erich Auerbach a dire che ci sono due modi per affrontare un dilemma: quello logico di Atene e quello narrativo di Gerusalemme. Sono entrambi necessari, e Montaldi e Alasia li padroneggiano entrambi (forse l’unica concessione alle modalità espositive delle scienze sociali del tempo è proprio la separazione fra il discorso analitico autoriale dell’ampio saggio introduttivo e quello narrativo delle storie di vita), ma fin dai capitoli dell’introduzione sulle periferie, sul parco, sui viali, ci si rende conto di come la modalità narrativa contamini l’esposizione saggistica. Perché il racconto esorbita sempre dalle aspettative a priori e dai limiti dell’interpretazione; digressivo, elusivo, carico di dettagli non richiesti e quindi più necessari, tessuto di vuoti pesanti e silenzi eloquenti, invaso dall’immaginazione e dal desiderio, il racconto è sempre più ricco di quello che possono dire un commento e un’analisi. Soprattutto, il racconto, specie il racconto della memoria, è una creazione individuale che sfida le necessarie astrazioni e generalizzazioni della sintesi quantitativa e statistica e ci mette sotto gli occhi l’immagine di un mondo fatto non di caselle rese identiche per renderle misurabili, ma mosaico di tessere una diversa dall’altra – di individui ognuno irriducibile e unico – che solo con immaginazione e partecipazione possiamo comporre in un insieme dotato di senso.
Le coree e le periferie milanesi raccontate in questo libro, allora, contengono molto più cose di quanto non ne prevedesse la nostra ragione indagatrice. Contengono il mondo antico che è ancora presente nella memoria e nell’identità – la terra del padrone che si misura in quattro ore di cavalcata per attraversarla, l’assalto dei briganti alla carovana in Molise, il memorabile viaggio dalla Sadegna a Milano attraverso Civitavecchia e Genova alla scoperta di un mondo nuovo, il primo cinematografo, la prima automobile, le guerre – e una modernità di carta fatta di licenze, tessere, permessi, verbali, multe, fogli di via, certificati, documenti… in un’Italia in cui le leggi fasciste ancora vigenti fanno di questi migranti dei clandestini indesiderati e senza documenti.
Mi rendo conto di stare facendo forse quello che Alasia e Montaldi volevano assolutamente evitare: leggere Milano, Corea come un “libro letterario” (mi viene in mente una celebre frase del romanziere afroamericano Richard Wright, che non voleva scrivere un libro su cui anche “le figlie dei banchieri” si potessero commuovere). Ma forse i tempi sono cambiati, e letteratura e sociologia hanno smesso di trattarsi reciprocamente come insulti – come sinonimi l’una per l’altra di genericità, approssimazione, sentimentalismo. Milano, Corea è un “libro letterario” perché fa spazio alla soggettività: la conoscenza sta sì nelle tabelle statistiche e nei documenti ma anche, forse soprattutto, nelle pieghe del linguaggio; la fatica e il desiderio dell’integrazione li percepiamo più nel linguaggio di un immigrato meridionale che usa una locuzione prettamente milanese (“ero dietro a dormire”) che in tanti dati oggettivi.
C’è molto altro, ovviamente, in Milano, Corea: per esempio, intuizioni taglienti sulle trasformazioni della politica, le divaricazioni che si vengono formando all’interno di una sinistra in cui qualche amministratore illuminato può vedere l’immigrazione come opportunità di crescita, in cui gli operai e i disoccupati immigrati iscritti al partito la vivono come sfruttamento, e in cui i sindacalisti stanno presi in mezzo. C ‘è, per chi legge oggi, l’inevitabile parallelo con l’immigrazione attuale, con la barriera di carta dei permessi di soggiorno dopo quella metallica dei respingimenti, e con le baraccopoli e i rifugi di fortuna che ancora si agglomerano intorno alle città. Ma la differenza è che, nonostante la quantità e la qualità di molte ricerche, un lavoro della portata e della profondità di Milano, Corea sull’immigrazione di oggi ancora lo stiamo aspettando.
Alessandro Portelli (pubblicato in Il manifesto, 27 gennaio 2011)
Articoli Correlati:
Attraverso l'Immigrazione: memorie dell'Europa orientale
Firenze, vene...
(Contro?)cultura in Urss: un’intervista sugli anni ’80
di Marco Gabb...
Storie di vita militare. Dalla tesi di laurea di Hilde Merini
Pubblichiamo ...
Esperienze di ricerca di storia orale: dal racconto alla storia
di Francesca ...
Fare storia orale al confine italo-sloveno: una nota a margine
di Vito Corpo...
