di Giulia Sbaffi
Questo articolo fa parte della rubrica “Interviste sull’intervista” per la quale rimandiamo all’introduzione di Francesca Socrate qui.
Riavvolgere il nastro, una premessa
Avevo concordato con Alessandro Triulzi di incontrarci a novembre. Ho ancora gli appunti del nostro primo incontro-dialogo iniziato, come dirà poi lui stesso, non da una serie di domande, ma da una tazza di tè. Alessandro lo conosco da qualche anno ormai, abbiamo la confidenza di affidarci l’uno alle impressioni dell’altra. Tuttavia, e come suggerisce Manlio Caligari in Cara Marietta, Caro Professore– che ho letto tardi, solo a margine della costruzione di questo testo-incontro – quando i materiali, che nell’oralità attengono a quel complesso insieme fatto di suggestioni, interferenze, incomprensioni e scambi vari, cominciano a circolare prima della conclusione di un lavoro succede che ci s’impara a conoscere faticando insieme. È sulla condivisa messa in relazione e restituzione l’uno della fatica dell’altro/a che si costruisce il lavoro.
La prima volta che accendo il registratore è inizio dicembre, io e Alessandro siamo nel giardino della Casa delle donne ad un centinaio di metri da quella della storia e della memoria dove ad intervista conclusa ci saremmo rincontrati come collaboratori di Archivio Memorie Migranti di Roma (insieme ad altri stiamo pensando di sistemare il sito dell’archivio). Dopo, perché durante l’intervista collaboriamo molto poco. Io devo stare attenta che il rumore dell’esterno non pregiudichi la qualità o che il mio fare caciarone non comprometta proprio la riuscita della registrazione. Soprattutto non ho una domanda precisa da fare all’inizio, perché è la stessa che ci portiamo da settimane nei nostri scambi telefonici, elettronici e di letture. Alessandro inizia il suo girovagare con tono pacato e una lucidità appuntita; tuttavia io non lo aiuto, non intervisto, non intervengo, non entro in relazione con quanto mi sta dicendo. Se di ciò mi fossi resa conto sul momento, probabilmente mi sarei accorta di star sbagliando tutto.
Si fa gennaio inoltrato e io ho cambiato città due volte in trenta giorni; la distanza fisica e temporale da quell’incontro rende molte delle impressioni momentanee di quel dialogo inintellegibili. Quando riascolto e trascrivo, mi rendo conto che in un’ora e dieci circa di intervista, io sono rimasta in silenzio quasi quaranta minuti. Un tempo che nei miei ricordi sembra incomprensibilmente lungo. Tra l’altro, sul finale ho inserito frammenti di conversazione e ho accennato un commento molto arzigogolato che sul momento mi sembrava potesse confermare una mia presenza, ma che poi nel riascoltarmi appare piuttosto come un’astratta interferenza.
Invio la trascrizione ad Alessandro e a quel punto l’intervista diventa miserabile per entrambi. Un aggettivo che stride completamente con la profondità, la ricchezza e persino la lucidità delle riflessioni proposte dal mio intervistato. Ci rendiamo conto che quello che manca è una messa in relazione partecipata tra me e lui di quei temi. Metto a fuoco i due personaggi; mi rendo conto di aver confuso la presenza ingombrante dell’intervistatore e del suo registratore con una totale sottrazione, di non aver radicato il racconto su di un terreno comune. Tanto è vero che Alessandro lo fa da solo e nella sua rilettura del testo mi suggerisce dove intervenire, si trasforma insomma in intervistato ed intervistatrice.
Decidiamo di incontrarci di nuovo, intanto fuori si è fatto aprile e il mondo è molto cambiato. L’unico spazio possibile per incontrarsi è quello digitale. Io ci arrivo da Parigi, lui da Roma. Tra me e lui ci sono quindici giorni di lockdown di differenza e una gestione molto diversa della pandemia. Conta qualcosa? Decisamente sì, perché quei giorni di vantaggio attivano in Alessandro la scaltrezza di proporre una serie di incontri a mezzo Zoom, con me ed altri nelle due settimane che precedono il nostro e dissodando così il terreno intorno a noi. Abbiamo preso confidenza del mezzo insieme, e nello spazio che è del registratore, ci abbiamo messo, a fare da supporto, il testo della nostra prima intervista: questa seconda sarà quindi una vera intervista sull’intervista!
Lo schermo del computer pur smaterializzando la presenza fisica dei nostri corpi, restituisce la prossemica dei silenzi e delle interazioni; Zoom insomma in maniera quasi lapalissiana mi spinge a confrontarmi col significato più proprio di un’intervista: uno sguardo l’uno sull’altra, la presenza di due corpi in relazione – sebbene in questo caso io senta molto più il mio nei miei 14 metri quadri di isolamento di quanto non veda quello di Alessandro richiuso in un quadratino e di quanto non senta la sua voce che fa eco nelle mie cuffie. L’assenza di un’interazione diretta si sente e questo attiva in me una maggiore partecipazione. Arriviamo così ad una solida conclusione: io faccio le mie domande, Alessandro aggiunge, contraddice, elabora. Mi incoraggia a partecipare, poi insieme ci confrontiamo e alla fine ci salutiamo. Nella ricostruzione del testo mi rendo conto che finalmente questo dialogo restituisce nel suo insieme tutto il lungo percorso di questa serie di incontri.
Il testo che segue è stato rivisto e riletto da entrambi, ci sono tagli, ma anche mancanze e qualche aggiunta: l’esportazione dell’audio di Zoom era compromessa e l’immersione nel dialogo non ha lasciato spazio a pause che forse avrebbero potuto ricostruire anche un’immagine fotografica di questa intervista che, a nostra insaputa, attraversa l’oralità pre e post Covid.
Alessandro Triulzi ha insegnato Storia dell’Africa all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ed oggi è presidente dell’Archivio delle Memorie Migranti.
Giulia Sbaffi è dottoranda presso il dipartimento di Italian Studies della New York University e si occupa di storia del lavoro sessuale in Italia tra anni 70 e anni 90.
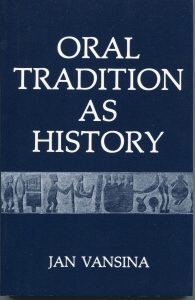
GIULIA: Come hai cominciato a fare le interviste e come hai incontrato la storia orale?
ALESSANDRO: Comincio dalle interviste … o meglio, come mi sono avvicinato alla storia orale, ognuno di noi ha i suoi percorsi individuali. Il mio è iniziato due anni dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università La Sapienza (siamo nei primi anni Sessanta, c’era una sola università statale a Roma), quando mi sono recato con una borsa Harkness negli Stati Uniti. Era l’estate del 1968: ero stato cacciato dal professore democristiano di cui ero “assistente volontario”, avevo vinto una borsa di studio che mi permetteva di specializzarmi all’estero, e sono andato prima negli Stati Uniti dove sono rimasto due anni come studente di dottorato alla Northwestern University, e poi in Etiopia dove ho fatto ricerche sul terreno per tre anni.
GIULIA: Ecco, una cosa che volevo chiederti dalla volta scorsa: perché gli Stati Uniti?
ALESSANDRO: Ero stato attratto dal Programma di Studi Africani della NU, uno dei centri di studi areali che allora sorgevano come funghi negli Stati Uniti anticipando, sia pure settorialmente, gli studi globali di oggi. In questi centri specialistici si confrontavano studenti, ricercatori e docenti che studiavano o erano originari dell’area oggetto di studi. Per me era un modo per studiare e conoscere da vicino l’altro africano, una realtà inconoscibile in quegli anni in Italia. L’America degli anni Sessanta, pur all’interno dei confini della guerra fredda, mostrava interessi strategici per il mondo esterno di cui, anche se in funzione anticomunista, voleva esplorare le geografie, studiare le lingue, conoscere le culture. Non a caso gli Area Studies sono stati spazzati via con la fine della Guerra Fredda.
In quegli anni, la Northwestern University era uno dei migliori centri di studi africani negli Stati Uniti; gli altri due erano la University of Wisconsin, dove insegnava Ian Vansina, e l’Università della California a Berkeley. Né Cambridge, né Harvard né Princeton erano allora interessati all’Africa; lo diventeranno più tardi con i Black Studies sugli Africani d’America. E’ stato alla NU che ho cominciato un percorso di studi professionale sull’Africa (a Roma mi ero laureato in una disciplina surreale, “Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici”, che aveva assorbito tutte le discipline di origine coloniale presenti nell’università italiana), ed è lì che ho potuto beneficiare di una full immersion nella storia politica, sociale e culturale di un continente che lottava per la sua indipendenza. Era per questa ragione che mi ero iscritto al dottorato di ricerca in Storia dell’Africa della NU. Venivo allora da un percorso generalista tipico di uno studente di Scienze Politiche, all’Africa mi ero interessato in seguito a un precedente soggiorno di studio negli Stati Uniti svolto dopo il liceo (con una borsa Fulbright a Middlebury College nel Vermont) e alle frequentazioni della libreria romana Paesi Nuovi di Marcella Glisenti a Piazza Montecitorio – allora un focolaio di interesse per le lotte del Terzo Mondo, l’unico luogo a Roma dove si poteva trovare una copia della rivista Présence Africaine che riuniva i nuovi scrittori della Negritudine. Capii allora che la disciplina di “Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici” non mi avrebbe portato da nessuna parte, e certo non mi dava alcuna possibilità di specializzarmi nel campo africanistico. Così sono andato negli Stati Uniti e sono rimasto lì due intensissimi anni di studi, di incontri e di insegnamenti fondamentali …
GIULIA: Hai scoperto allora cosa fosse la storia orale?
ALESSANDRO: Sì, è lì che mi sono imbattuto nella storia orale, da subito. Gli anni ’60, che oggi ricordiamo per le rivolte studentesche, la guerra del Vietnam e il grande concerto di Woodstock, per l’Africa voleva dire la prima decade delle indipendenze di un continente che lottava per liberarsi dal colonialismo. Il 1960 è stato anche l’anno in cui uno sconosciuto storico belga, Ian Vansina, pubblica il libro De la tradition orale, un libro e un programma di ricerca per noi basilare come fonte primaria per cominciare a studiare la storia dell’Africa non più sulle fonti coloniali europee ma dall’interno. Prima di iscrivermi alla Northwestern, avevo avuto una lunga corrispondenza con Vansina che insegnava allora all’Università del Wisconsin ma quell’anno era in sabbatico. Il consiglio di andare alla Northwestern mi venne da lui. Mi disse che in America ci si poteva spostare facilmente da università a università, e che NU aveva un buon sistema di scambi con altre università vicine, in particolare con Chicago dove insegnavano importanti antropologi e sociologi africanisti. Così andai alla Northwestern dove naturalmente, studiammo l’opera di Vansina da cima a fondo e dove, quando potevo, andavo a seguire i corsi all’Università di Chicago.
Lo studio della tradizione orale aprì così il mio ingresso nel mondo dell’etnostoria, l’unico modo che avevamo allora per entrare più a fondo nelle culture e la storia di luoghi lontani e distanti. Per molti di noi il libro di Vansina diventò una specie di idolo: la storia orale era per definizione l’anti-storia coloniale, l’anti-storia degli europei in Africa, che era l’unica storia conosciuta e diffusa nelle università di tutto il mondo, comprese le università africane, fino agli anni ‘60. Il 1960 irrompe così nella storiografia a livello globale e riflette un’importante cesura rispetto allo studio del continente imponendo uno sguardo nuovo che partiva dallo stesso oggetto di studio trasformato in soggetto: africani e africanisti da allora erano chiamati ad indagare sulle radici storiche interne al continente e non più sulla storia della presenza europea in Africa. Il libro sulla tradizione orale di Vansina diventò una specie di bibbia dei neofiti africanisti: per studiare l’Africa bisognava viverci, La Tradizione Orale e il registratore a nastri erano gli unici strumenti disponibili per la sua conoscenza.
Questo è stato l’inizio, ed è stato un inizio importante anche se manicheo per molti di noi. In quegli anni si pensava che l’oralità fosse l’unica forma di espressione storica che appartenesse, ed esprimesse, l’Africa della decolonizzazione, un continente che si voleva liberare dalle strutture di potere ereditate dal colonialismo, “l’odore del padre” come lo chiama Mudimbe.
GIULIA: Però tu non eri uno storico di area come hai fatto?
ALESSANDRO: Ho avuto la fortuna di studiare storia con specialisti areali, soprattutto studiosi e ricercatori che avevano vissuto a lungo e fatto ricerche sul terreno in Africa. Tra questi, ricordo in particolare Ivor Wilks, uno storico inglese degli Ashanti che aveva vissuto 17 anni in Ghana e William Shack, un antropologo afroamericano di Chicago che aveva lavorato a lungo tra i Guraghe dell’Etiopia meridionale. Furono loro, oltre a Vansina, i miei mentor africani.
Fin dagli inizi, così, mi sono trovato a metà strada tra antropologia e storia. In quel momento si pensava che bastasse scavare sotto la sabbia per trovare la vera storia dell’Africa, una concezione che più tardi avremmo rivisto, ma in quel momento era un fortissimo stimolo alla ricerca di fonti e metodi per la ricostruzione della nuova storia del continente. Questo valeva anche per le lingue africane, molte delle quali erano insegnate alla Northwestern: lì ho appreso i primi rudimenti di swahili, di arabo, e infine di amarico una volta deciso che la mia tesi l’avrei scritta sul terreno in Etiopia. Questa vicinanza e interesse per la cultura dell’oralità me la sono portata dietro prima in Etiopia e dopo in Italia. Mi ricordo che Ivor Wilks, un africanista, grande esperto della storia orale del Ghana, nel corso dei suoi seminari simulava di essere lui un anziano africano intervistato dai dottorandi che cercavano di carpirgli informazioni a cui invariabilmente rispondeva in modo del tutto reticente e per monosillabi. Wilks ci faceva capire, già allora, che l’intervista, come l’insegnamento (era uno straordinario insegnante) è sempre una relazione, e che le relazioni vanno create e non subite o imposte. Se non c’è relazione vera, non ci può essere intervista. Cosa che per noi lì per lì non era molto chiaro, ma di cui avremo fatto presto esperienza sul terreno. La storia orale già allora era un “mestiere” che dovevi apprendere praticandolo, non solo studiando modelli e teorie.
GIULIA: Sì, ma che mestiere è? E soprattutto, tu quando hai acceso il registratore la prima volta?
ALESSANDRO: Beh, parte di questa esperienza fu quella, per me assolutamente straordinaria, di essere mandato in Africa tra il primo e il secondo anno di dottorato a spese del governo federale – illegalmente perché formalmente erano ammessi soltanto studenti americani, ma il direttore palestinese alla guida del programma riuscì, in qualche modo, a farmi entrare nel piccolo gruppo degli apprendisti fieldworker di NU. Nell’estate del 1969 un gruppo di noi fu così mandato all’università di Legon in Ghana a fare un tirocinio di ricerca sul terreno. Quel mese e mezzo è rimasto un momento fondamentale nella mia preparazione. Ricordo che andai a fare ricerca nella zona di Kumasi, capitale dell’Ashanti, una popolazione dell’interno. I 45 giorni di ricerca erano organizzati in maniera molto precisa: si stava 10 giorni con una equipe di ricerca guidata da uno storico dell’Università di Legon che guidava studenti senior, si imparava il mestiere del ricercatore di terreno partecipando alla ricerca di altri, ma si imparava anche che cosa voleva dire stare in un gruppo di ricerca, ascoltare la sera i racconti degli altri, capire i propri sbagli, e i molti strati di significato di un racconto o di una tradizione. Al termine di questa breve formazione sul campo, per tre settimane si era lasciati soli a fare ricerca coadiuvati da uno studente del posto su un tema assegnato prima di tornare alla sede di Legon dove bisognava “restituire” quello che si era preso (e appreso) dal terreno.
GIULIA: Ma quindi c’era qualcuno che faceva l’intervista per voi? Che interferiva, che mediava, che era tra te e l’intervistato?
ALESSANDRO: Naturalmente avevamo bisogno di interpreti, noi non parlavamo le lingue locali, quindi bisognava avere sempre accanto uno studente della zona dove si svolgeva la ricerca, poi si doveva tornare a Legon e, prima di partire, bisognava sbobinare i testi delle interviste, batterle a macchina e depositarle presso la biblioteca dell’università. È stata una corsa con il tempo, ma anche un esercizio fondamentale; intanto perché ci ha insegnato che sul terreno si fa ricerca e si riflette, e si scrive, su quello che si è fatto quotidianamente, non si registrano decine di nastri rimandando l’ascolto al ritorno. I nastri si riascoltano la sera, solo così puoi capire quello che hai raccolto quel giorno e quello che devi fare il giorno dopo. E poi mi ha insegnato una cosa fondamentale: non c’è ricerca senza restituzione. Il ricercatore deve saper prendere ma saper anche restituire. La restituzione che il Dipartimento di Storia dell’Università di Legon aveva pensato per noi studenti stranieri in formazione era che le fonti da noi raccolte andavano tutte depositate nella biblioteca dell’Università in modo che altri potessero beneficiarne. Gli storici dell’Africa sperimentavano così nuovi strumenti di ricerca e di insegnamento sul terreno e non più sui libri di storia europea.
GIULIA: Eravate un gruppo di pari? tutti studenti?
ALESSANDRO: Mi ricordo che eravamo una manciata di studenti, tutti provenienti dall’Università di Northwestern, alcuni anche africani. Che il seminario fosse offerto ai dottorandi come esercitazione sul terreno con fondi federali del programma di studi areali era una cosa impensabile in Italia. In 45 giorni occorreva fare “pratica” di terreno in una università africana di nuova indipendenza e lasciare il prodotto della propria ricerca in modo che altri potessero beneficiarne. Ricordo la fretta, e l’euforia, di quel lavoro, che implicava sbobinare i nastri, battere le trascrizioni sul ciclostile, correggere, stampare più copie delle interviste, ecc. Lasciai copia delle interviste fatte a Kumasi alla biblioteca di Legon. Da quelle interviste uscì il mio primo articolo sulla rivista dell’International African Institute di Londra, il primo articolo scientifico della mia vita. Anche se non sono diventato uno studioso di storia del Ghana, il metodo me lo ha insegnato il terreno, me lo ha insegnato l’Africa.
GIULIA: E quando sei tornato in Italia che…storia orale hai trovato?
ALESSANDRO: Tornato in Italia naturalmente ero diventato convinto sostenitore di questo metodo e ho curato l’edizione italiana de La Tradition orale di Vansina in una collana di antropologia per Officine Edizioni nel 1977. L’anno prima, con Carlo Poni e Bernardo Bernardi, avevamo organizzato una conferenza all’Università di Bologna su Fonti orali: Antropologia e storia (Angeli, 1978), poi considerata la prima conferenza della “Oral History” a livello internazionale.
La conferenza di Bologna, a cui parteciparono molti studiosi italiani e stranieri, tra cui lo stesso Vansina, ha permesso di innestare la storia dell’Africa nella storia delle culture operaie e contadine europee, e di far dialogare la tradizione di studi ereditata da Ernesto De Martino e da Gianni Bosio con la tradizione orale portata avanti da storici italiani e europei (Carlo Poni, Paul Thompson, Terence Ranger…). Erano due “sud” che per certi versi e per casi fortuiti si incontravano non a caso in Italia e a Bologna: il nostro sud era solo un po’ più a sud degli storici orali italiani. Per la prima volta ci fu un incontro-dialogo, mai più ripetuto su questa scala, tra storia orale africana e storia orale italiana. Bologna non solo permise un fertile scambio di idee e di contaminazioni (riprese in un numero della rivista Studi Storici l’anno dopo) ma poi abbandonate (l’unico altro numero della rivista interamente dedicato ad argomento africano uscirà più di venti anni dopo, nel 2002), e tracciò la strada di un possibile percorso comune che però non fu seguito.
GIULIA: A cosa ti riferisci?
ALESSANDRO: La storia orale italiana ha continuato la sua strada mescolandosi con le storie orali di alcuni paesi europei e soprattutto, grazie a Sandro Portelli, nordamericani mentre la storia africana ha continuato i suoi percorsi interni al continente nero. Ma con Sandro P. ci sentivamo di tanto in tanto, e quando noi – come Archivio delle Memorie Migranti appena costituito – alla fine del 2011 ci siamo messi a cercare casa e ospitalità dopo i lunghi anni di lavoro comune nella Scuola Asinitas di Via Ostiense, andai con Giulio Cederna da Sandro a Villa Mirafiori chiedendo un alloggio anche temporaneo per il nostro piccolo archivio di film e di racconti di migranti. Con grande generosità e, secondo me, intuito, ci ha subito detto: «Ma venite da noi, non c’è nessun problema!». E così noi, “fisicamente” abbiamo ricongiunto nel 2012 una storia iniziata nel 1976 iniziando una serie di collaborazioni e iniziative che da allora abbiamo condiviso con il Circolo Bosio. Roma Foresteria, una collana di canti di persone migranti, è stato il primo prodotto di una nuova collaborazione tra studiosi, archivisti, e migranti che venivano da diversi orizzonti di vita e di ricerca, ma che si identificavano con gli obiettivi e i metodi della storia orale partendo dal lavoro più che decennale del Circolo Gianni Bosio ospitato presso la Casa della memoria e della storia.
GIULIA: Mi sembra però che una traccia sia rimasta, quella…politica.
ALESSANDRO: Per me, incontrare la storia orale sul terreno prima in America e poi in Etiopia, e adeguarmi ai suoi insegnamenti negli anni in cui la nuova Africa si andava formando parallelamente al primo nucleo degli African American Studies e i movimenti di liberazione (dalle Pantere Nere a Black is beautiful) ha fin dall’inizio inserito i miei studi in una dimensione apertamente anticoloniale, così come lo era fortemente la nuova disciplina degli inizi. Anche se poi la storiografia in Africa ha seguito tutto un suo percorso, che qui non è possibile ripercorrere, la storia orale, nata per dare una coscienza politica ai nuovi Stati che stavano nascendo in Africa, si è interrogata più sull’esperienza dello Stato che sulla crescita della società volgendo il suo sguardo, come dire, più alle istituzioni che alle persone che avevano contribuito all’affermazione o deformazione dello Stato, e lo ha fatto paradossalmente in un periodo storico, la fine degli anni Sessanta, quando lo Stato veniva messo in discussione ovunque, anche in Africa.
GIULIA: Eravate studenti, lo eravate negli anni ’68. L’uso dell’intervista come metodo partiva da lì?
ALESSANDRO: Chi ha vissuto il ‘68 in America ricorda le manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, la partecipazione ai primi movimenti studenteschi che in quegli anni erano fortissimi – soltanto ora sotto Trump si assiste a un ritorno di ribellione studentesca contro le politiche dell’establishment – il rifiuto di andare a combattere in Vietnam, le marce nei campus o per le strade con i figli in spalla… Io vivevo nella Chicago del sindaco Daley, odiatissimo dai contestatori dell’establishment, quindi il confronto con il potere era sempre molto duro, con cariche della polizia, dimostrazioni fuori dai campus, rischi di essere fermati. Sono stato contento di fare questa esperienza, perché ci confermava nella convinzione che il nostro vivere nella storia era parte del più ampio studio del passato, e che la storia orale, a bene intendere, andava vista come una “pietra d’inciampo” nel maturare nuove consapevolezze e domande sul presente. La storia non era solo qualcosa che ti faceva conoscere il passato, ma ti permetteva di agire sul presente. In un certo senso, l’oralità, le interviste ai testimoni, le tradizioni orali erano per noi un modo non solo di raccogliere le voci del passato ma di vivere il presente con maggiore consapevolezza, ci permettevano di ricostruire il tessuto connettivo di un flusso storico più ampio che nasceva all’interno delle nostre stesse società e coscienze. Non ci interessava soltanto la reazione alle pressioni esterne del potere, ci interessava la nuova agency, la soggettività, il protagonismo degli africani che agivano, e non solo reagivano, al periodo coloniale come soggetti di vita propria.
L’altra esperienza fondamentale è stata la ricerca sul terreno “partecipata” attraverso “persone di contatto”, come le chiama Pierre Bourdieu, che permettevano da un lato l’accesso diretto alle fonti ma richiedevano anche la costruzione di continue relazioni con i soggetti-oggetti della ricerca che ti ancoravano, e vincolavano, al terreno. L’esperienza di andare in un paese di cui non conoscevo la lingua, come era stato in Ghana, e di dovermi appoggiare su studenti dell’università che venivano dalle zone di ricerca per costruire una relazione con gli abitanti del posto, ha posto fin dall’inizio l’accento sull’importanza di questi intermediari per favorire uno spazio di condivisione capace di sostenere e nutrire la ricerca sul terreno. In questo comune spazio di ascolto, le altre persone presenti agli incontri caratterizzavano il contesto comune di ascolto e di narrazione permettendo sia all’intervistatore che all’intervistato di interiorizzare le domande e di renderle fruibili all’interno di una relazione di empatia, o di dissenso, che rispecchiava la stratificazione delle differenti opinioni sugli eventi narrati. Nel breve soggiorno di ricerca tra gli Ashanti, avevo lavorato su un una particolare assemblea di commoner letterati Ashanti, l’Asanteman Council, riproposto dall’amministrazione coloniale inglese negli anni ‘30 per contrastare l’autorità dei capi tradizionali. Trattandosi di ex-funzionari dell’amministrazione coloniale, i miei informanti di Kumasi erano tutte persone che avevano studiato nelle scuole pubbliche e con cui potevo parlare in inglese; avevo cercato apposta un tipo di argomento in cui potevo servirmi della lingua inglese come terreno di mediazione per la costruzione di un rapporto diretto con i miei intervistati. Ma anche in questo caso, era inevitabile servirsi di un appoggio locale che mediasse la mia ingombrante presenza di ricercatore esterno rispetto al terreno e all’argomento della ricerca, oltre al cibo e la socialità. Questa esperienza di intervistare con qualcuno accanto, così in Ghana come più tardi in Etiopia, mi è stata molto utile quando ho cominciato a fare le prime interviste con persone migranti.
GIULIA: Dunque anche in Etiopia, la storia orale aveva questa ambizione? Che interviste hai fatto lì?
ALESSANDRO: In America e poi in Etiopia avevo studiato l’amarico, poi per conto mio l’oromo (i due gruppi linguistici più numerosi dell’Etiopia), ma una volta arrivato sull’altopiano etiopico ho scoperto che il mio “terreno” – la periferia etio-sudanese dove svolgevo la mia ricerca – era abitata da una varietà di gruppi etnici spesso mescolati tra loro le cui lingue erano sconosciute a volte agli stessi linguisti. Quindi, fin dall’inizio, il terreno in Etiopia andava costruito sulla base di relazioni (spesso studenti dell’Università di Addis Abeba che facevano loro stessi ricerca) cioè con altre “persone di contatto” che potevano facilitare le mie ricerche, aiutarmi a tradurre e trascrivere le interviste, e soprattutto coinvolgere gli informanti nel lavoro di ricostruzione storica e continuare le interviste quando ero assente dal terreno, per es. durante la stagione delle piogge quando il terreno argilloso dell’altopiano si trasforma in fanghiglia impercorribile. Questi contatti “mediati” con studenti di Addis Abeba, se limitavano il mio confronto diretto con i testimoni locali, permettevano una connettività e partecipazione alla ricerca di più persone che si traduceva in una pluralità di informazioni straordinaria.
Sono andato in Etiopia nel 1970, erano gli ultimi anni dell’imperatore Hailé Selassié. Lavoravo all’Università di Addis Abeba come ricercatore straniero. Allora all’Università di Addis Abeba (l’unica università del paese) era richiesto a tutti gli studenti del 3° anno di svolgere un anno di servizio in una scuola periferica della regione da cui provenivano. In quegli anni, gli studenti universitari erano un’assoluta élite nel paese e le autorità universitarie cercavano di ridurre la distanza sociale aggiungendo ai quattro anni di studio un quinto da effettuare in aree svantaggiate del Paese. Stabilii dunque dei contatti con gli studenti di storia dislocati nelle mie aree di ricerca nell’ovest del paese, allacciando rapporti e contatti, e condividendo con loro l’idea di ripartire dal basso, attraverso l’oralità, e dalla periferia per riscrivere una storiografia allora fortemente accentrata sulle istituzioni del centro politico-religioso del paese: la monarchia, la nobiltà e la Chiesa. Non fu certo difficile. Gli studenti etiopi dei primi anni Settanta erano fortemente coinvolti nella vita politico-culturale del Paese, erano molto critici del “sistema feudale” di Hailé Selassiè che contestavano, e cointeressati nella sfida di restituire storicità alle strutture locali e regionali del sistema di potere. Per gli studenti che provenivano dalle regioni più lontane dal centro fu facile adottare la periferia come punto di osservazione e di critica del centro. Rientrati nei luoghi di residenza per condurre ricerche di tesi, si sentivano cointeressati nella ricostruzione della storia locale e regionale prima dell’arrivo dei nuovi “colonizzatori” – che nella situazione etiopica voleva dire l’arrivo delle genti Amhara dell’altopiano e delle loro strutture di potere alla fine del secolo diciannovesimo. Tutto questo ha portato al forte coinvolgimento di un gruppo di studenti e ricercatori locali che si sono associati in un comune progetto di storia della periferia etiopica (il dar ager) collaborando alla scoperta di nuove fonti e individuando molta documentazione inedita ricavata da informatori e gruppi locali. Il risultato non si è fatto attendere: le 900 pagine di interviste orali svolte nella regione del Uollega occidentale tra il settembre 1970 e la fine del 1973 costituiscono un prezioso apporto alla conoscenza della storia dell’ovest etiopico negli ultimi anni del regime imperiale prima della sua disgregazione con il conseguente spostamento di popolazioni e lo scoppio di conflitti interni legati all’affermazione del nuovo regime socialista imposto dai militari del Derg. Attraverso queste fonti orali e le cronache locali individuate con l’aiuto di studenti di Addis Abeba nella regione dell’ovest etiopico nei primi anni Settanta, è stato possibile elaborare un profilo di storia regionale in un’area del paese che verrà sconvolta nel periodo del Derg.
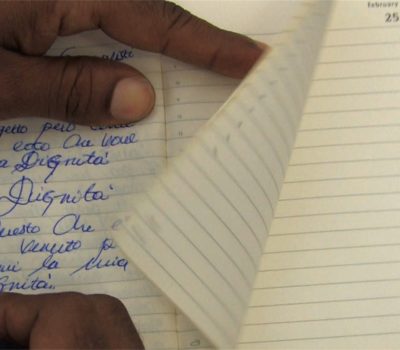
GIULIA: Parlando della relazione tra intervistatore e mediatore, una cosa che ho notato riguardando questa intervista è il riferimento all’auto-narrazione dei migranti. Che relazione c’è per te tra le interviste fatte quando eri ricercatore e il tuo lavoro di oggi con l’Archivio?
ALESSANDRO: Ho cominciato ad occuparmi di migrazioni dopo molti anni di studio e di va e vieni con l’Africa, l’Etiopia soprattutto ma anche il Sudafrica, dove mia moglie Paola ed io avevamo amici e facevamo ricerca. Tutto è cominciato quando, alla fine degli anni ’90, inizi 2000, ho cominciato ad interessarmi agli africani sparsi che vedevo agli angoli delle strade, negli autobus, e che sentivo parlare lingue di cui riconoscevo i suoni o le parole. In un periodo in cui la migrazione non era ancora sotto pressione come oggi, cominciai a chiedermi: chi sono queste persone? perché vengono da noi? come vivono? come arrivano da noi? Ho cominciato a leggere, a informarmi. Ricordo il primo libro che lessi su questo argomento, Io venditore di elefanti di Pap Khouma. Il libro mi aprì gli occhi ma ripropose allo stesso tempo il disagio più volte provato nelle ricerche di terreno in Africa. Capii subito l’importanza di avere racconti vivi e diretti come quelli di Pap Khouma, ma mi resi presto conto che il “terreno” praticato vicino a casa richiedeva la stessa necessità di avere un contatto diretto con le persone migranti per poter costruire i rapporti necessari alla condivisione di storie. Il libro di Pap Khouma mi colpì per la ricchezza di soggettività e per la determinazione che caratterizzava i vari protagonisti della migrazione, una ricchezza individuale che occorreva mettere in assoluta evidenza specie in un periodo in cui i migranti erano considerate prevalentemente “invasori” o “vittime” di macchinazioni e sfruttamento altrui.
Poi venne l’occasione propizia: mi chiamò Marco Carsetti per una richiesta di aiuto. Marco era un collaboratore de lo straniero, la rivista diretta da Goffredo Fofi, con lui e altri avremo più tardi fondato l’Associazione Asinitas. Mi disse: «Abbiamo qui una donna oromo dell’Etiopia la cui storia non capiamo bene. Tu hai lavorato con gli Oromo in Etiopia, ci puoi dare una mano?». Ovviamente dissi di sì. Avevo lavorato a lungo in zone oromo dell’Etiopia occidentale e ne conoscevo le vicende. La donna oromo in questione si chiamava Taiba, era arrivata in Italia dal Sudan dove era rifugiata con il figlio di 4-5 anni, Robera; cominciammo ad incontrarci con lei. Gli incontri si svolgevano in una sede distaccata di Medici contro la tortura, una istituzione di volontariato di psicologi e psichiatri coinvolti con persone che avevano alle spalle esperienze traumatiche. Uno di questi medici che aveva un rapporto privilegiato con noi ci parlò della difficoltà di affidare l’azione di cura del trauma unicamente all’interno del rapporto faccia a faccia con il/la paziente; suggerimmo, e loro accettarono, che i racconti potessero essere condivisi all’interno di piccoli gruppi di persone che avevano attraversato le stesse esperienze, in cui il rapporto tra terapeuta e paziente veniva mediato dalla condivisione di un vissuto comune e da uno “stare insieme” all’interno di una stessa situazione di disagio per farne affiorare gli elementi attraverso un raccontarsi reciproco e circolare. La narrazione del trauma passava così attraverso una condivisione sia con altri partecipanti al gruppo che parlavano, reagivano e assistevano alla narrazione, sia con quelli che erano passati attraverso esperienze simili. Questo è stato il primo insegnamento importante, un insegnamento che confermava i silenzi caratteristici di ogni sopravvissuto a guerre, violenze e orrori del contemporaneo; i sopravvissuti hanno grande difficoltà a parlare e, specie agli inizi, sono convinti che ciò che hanno vissuto non è condivisibile se non da persone che hanno condiviso la stessa esperienza di vita. In qualche modo, ogni intervista sul vissuto di profughi e rifugiati è essa stessa traumatica. Tanto più, quando la disparità tra l’intervistatore e l’intervistato passa attraverso un assoluto squilibrio di quadro culturale d’origine, di lingua, di condizione di vita, tra intervistatore estraneo e straniero come quello che si verifica nel paese di arrivo con i migranti di oggi.
In qualche modo, le interviste e le auto-narrazioni raccolte tra i migranti mi riportavano all’esperienza di ricerca fatta in Africa. Dopo il Ghana sono andato in Etiopia dove ho vissuto e fatto ricerche sul terreno per tre anni. E anche lì, pur essendo l’Etiopia caratterizzata da una tradizione di scrittura di lunga data, la scelta di fare ricerca al confine tra Sudan ed Etiopia mi ha costretto a fare i conti con l’oralità tipica delle società agro-pastorali del continente africano e a servirmi di questa oralità per bilanciare i silenzi delle fonti scritte spesso agiografiche o annalistiche del centro politico (Addis Abeba) da cui erano sostanzialmente ignorate. Trent’anni dopo, meccanismi simili di partecipazione e di coinvolgimento di voci provenienti dall’interno del composito mondo dei migranti ci hanno aiutato a riflettere intorno alla creazione di un archivio di memorie migranti (AMM) e alla formulazione dei suoi metodi e pratiche. Per me è stato normale proseguire in armonia con il mio passato di ricercatore. Ho scoperto leggendo le opere di Bourdieu …
GIULIA: … e di Sayad
ALESSANDRO: e di Abdelmalek Sayad, il suo collaboratore più stretto. Bourdieu scrive alla fine del volume dedicato alle inchieste orali sulle aree periferiche urbane di Parigi, La misère du monde, un capitolo straordinario che intitola Com-prendere, lo facevo leggere sempre ai miei studenti di Napoli, dicendo: «Se volete capire cos’è una intervista, dovete leggere queste trenta pagine».
Bourdieu aveva iniziato le sue ricerche negli anni ‘50 intervistando i contadini algerini inurbati al cui interno si agitava la ribellione nei confronti delle politiche dell’amministrazione francese che avrebbe animato la lotta di liberazione (1954-62). Lui, allora arruolato nelle truppe francesi di occupazione, chiede e ottiene di fare ricerca sulla malaise dell’Algeria, e cerca di capire e poi spiegare ai suoi connazionali perché gli algerini avvertivano come oppressiva la mano coloniale della amministrazione francese. E mette in evidenza da subito la pietra d’inciampo, l’ineliminabile asimmetria che divide lui, l’intervistatore francese colonizzatore che fa domande, e il “dannato della terra” locale che risponde, entrambi parte di un sistema obiettivo di assoggettamento particolarmente opprimente in un periodo conflittuale come quello in cui viene effettuata la ricerca, un confronto quasi “di guerra”, non meno duro di quello che c’è oggi tra noi e …
GIULIA: … e i migranti.
ALESSANDRO: Sì, i migranti, con cui è in atto da anni un informale anche se alterno conflitto non dichiarato da parte dello Stato italiano e delle sue istituzioni. Anche noi di Asinitas, e poi dell’Archivio, ci siamo trovati a operare in una situazione di piena ostilità istituzionale con cui occorreva fare i conti se si voleva ricreare un contesto di contiguità e vicinanza necessario all’ascolto di persone/voci migranti. Questo contesto è stato creato attraverso la scuola di italiano di via Ostiense (Roma) dove ogni giorno affluivano i migranti che volevano imparare l’italiano. E nella scuola Asinitas, una scuola che seguiva gli insegnamenti liberi del MCE (Movimento di cooperazione educativa) e di Célestin Freinet, si praticava l’insegnamento dell’italiano non sui libri, ma attraverso le storie, i gesti e le parole che uscivano dai loro racconti e avvicinavano il loro mondo a quello nostro. L’insegnamento dell’italiano passava quindi attraverso la registrazione di racconti, favole, ricordi e continui collegamenti tra il mondo di origine e quello di arrivo. Occorreva anche qui saper individuare, coltivare e mantenere un contesto di ascolto e di partecipazione che fosse il frutto diretto di una relazione di fiducia – che Bourdieu chiama contrat de confiance – capace di diminuire l’asimmetria di fondo tra intervistatore e intervistato. L’asimmetria dell’ascolto si basa su varie forme di differenze che sono anche distanze tra chi parla e chi ascolta. Per me l’esperienza di Asinitas è stata molto importante, perché mi ha permesso di confrontarmi con la doppia asimmetria di lingua, di cultura, di classe di cui parla Bourdieu, che si è sommata, prima in Africa e poi tra i migranti arrivati in Italia, con l’asimmetria di chi vive nel proprio ambiente dove ha casa, protezione e affetti, e chi non ha tutto questo e vive “aggrappandosi” alla nuda vita e ai rapporti giorno per giorno nella speranza di un futuro migliore. Naturalmente l’asimmetria tra chi fa domande e chi risponde non c’è solo tra noi e i migranti, c’è anche quando Sandro Portelli va e interroga un operaio di Terni o quando De Martino interroga un contadino in Calabria…
GIULIA: O Revelli …
ALESSANDRO: … o Revelli in Piemonte. Però nel lavoro di interviste con i migranti la nostra asimmetria con la loro condizione è smisurata: quando non condividi quasi nulla a livello di base (cultura, lingua, identità, religione o ricchezza), quando lo stacco è così forte, la necessità di creare una relazione è ancora più forte.
GIULIA: e allora come hai fatto? attraverso la relazione che stabilivi con gli interpreti?
ALESSANDRO: Ho capito che, come già in Ghana e poi in Etiopia, occorreva individuare “persone di contatto” tra noi e i migranti e che queste persone dovevano venire dallo stesso mondo degli intervistati. Se c’è un metodo nel lavoro che noi chiamiamo “partecipato”, è quello di capire che non si tratta di noi (“buoni”) che vogliamo aiutare altri in difficoltà, ma di un sistema di condivisione per quanto possibile paritario capace di trasmettere non solo l’intenzione ma la prassi di un lavoro comune. Di qui, sono nato i primi “VP” (video partecipati) con il regista etiope Dagmawi Yimer o il giornalista somalo Zakaria Mohamed Ali, le prime interviste fatte ad Asinitas con l’aiuto dei mediatori e il ‘cerchio narrativo’ che ebbe luogo nel 2008 con un gruppo di ragazzi somali che vivevano nell’allora CIE (Centro per identificazione ed espulsione) di Castel Nuovo di Porto. Il cerchio narrativo si basava su una serie di racconti circolari ripetuti, ripresi, scambiati tra noi e fatti sedimentare insieme a un gruppo di giovani provenienti dalla Somalia e da Gibuti: ci vedevamo una volta al mese per tutta una giornata, ci disponevamo in cerchio, e ci scambiavamo racconti e ricordi: da un lato sette-otto ragazzi somali che riflettevano sulle ragioni e le condizioni del loro viaggio migratorio, dall’altro due operatori di Asinitas (Dagmawi e Sintayehu) che avevano fatto il viaggio insieme dall’Etiopia: in mezzo, Igiaba Scego che scriveva le sue impressioni in un “Taccuino di bordo”, Cristina Ali Farah che ci aiutava a riflettere sui termini somali di riferimento usati nei dialoghi del cerchio, e una mediatrice somala, Zahra, che traduceva tutto quello che veniva detto. Dag filmava, Sintayehu registrava. Marco ed io guidavamo la discussione, portavamo in classe letture e riflessioni (di Tayeb Salih, di Nuruddin Farah, ecc.), ricucivamo silenzi e tensioni narrative. Ho rivisto recentemente questi testi per un intervento e mi sono ritrovato nel modo “partecipato” di stare insieme nel cerchio, nel condividere una giornata tutta spesa a trovare le “parole per dirlo”, dal buufis tradizionale dei nomadi somali continuamente alla ricerca di pascoli più fertili per le loro mandrie, al tahrir, l’uscita dal paese dei giovani somali per ricostruire la propria vita in un posto nuovo. Fin dall’inizio è stato chiaro che non eravamo lì per ascoltare una storia da recitare poi davanti a una giuria o commissione per l’asilo; nel cerchio volevamo ascoltare e narrare a turno, far uscire la soggettività di tensioni, desideri, speranze, delusioni, i momenti di luce e di buio della faticosa “migrazione al nord” di tanti giovani africani arrivati di recente che si confrontava con il non minore spaesamento e disagio di noi spettatori-attori del complesso e drammatico “enigma” dell’arrivo.
GIULIA: Una sorta di intervista collettiva…
ALESSANDRO: È stata questa impostazione, credo, che ci ha permesso di avere dei materiali narrativi più diretti e significativi di quelli presentati d’ufficio. Tra trenta-quarant’anni, quando si apriranno gli archivi e verranno fuori i verbali delle commissioni si vedrà meglio quale stacco ci sia tra le storie formali registrate come richiesta di asilo e quelle che sono state raccolte all’interno di una relazione di ascolto attivo. Questo interesse per l’auto-narrazione (il racconto di sé come espressione libera di soggettività non finalizzato all’ottenimento di un diritto o di un permesso di soggiorno) è stata la spinta che ci ha portato ad abbracciare iniziative pubbliche come il Concorso annuale DiMMi-Diari Multimediali Migranti insieme con l’Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, o di organizzare con la Cineteca di Bologna e altre associazioni il Premio Mutti di cinema migrante che ogni anno permette a un regista straniero residente in Italia di fare un film di finzione o un documentario, e di conservare queste storie attraverso un fondo apposito istituito presso l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, l’ex-Discoteca di Stato, di Palazzo Caetani a Roma.
Naturalmente tutto questo lavoro fatto da poche persone, con pochi mezzi, è solo una goccia nel grande mare dello storytelling contemporaneo. Questo ascolto diretto delle voci migranti rappresenta un modo di stare vicino a persone che arrivano da noi in condizioni spesso disperate e di aiutarle a “testimoniare” malgrado il clima ostile di mancato ascolto e accoglienza. Penso che queste testimonianze inattuali e spesso inascoltate del contemporaneo, forse inattese tra i più, saranno importanti domani per capire come è cambiato il mondo intorno a noi.
GIULIA: Una specie di uso decoloniale del metodo dell’oralità, è questo che proponi?
ALESSANDRO: I racconti dei migranti fanno emergere, la sostanziale durezza e incapacità dell’Europa, a distanza di sessanta-ottanta anni dalla fine del periodo coloniale, di fare i conti con l’esperienza della soggiogazione e del dominio di un popolo su un altro. Il grande spaesamento e frammentazione di coscienze espresse dall’Italia di oggi sulla condizione migrante deriva da una sostanziale non accettazione della diversità in un paese che ha codificato le leggi razziali negli anni ‘30, ha amnistiato i suoi reati e non ha mai fatto un vero esame di coscienza sul periodo coloniale e i suoi nefasti immaginari che oggi si ripercuotono sul rigetto delle aspettative e dei diritti degli ex-colonizzati, e oltre. Non c’è dubbio, dal mio punto di vista, che i migranti siano oggi il nuovo soggetto coloniale, gente costretta quotidianamente ad abbassare la testa, che si “integra” perché non può farne a meno ma accumula dentro rabbia e rancori, un potenziale distruttivo che domani potrà esplodere se non viene combattuto oggi nella prevenzione. Per questo motivo abbiamo incoraggiato i nostri amici dell’Archivio Diaristico Nazionale, con cui abbiamo un rapporto privilegiato da anni, a andare oltre la diaristica rendendo possibili espressioni di sé che sappiano conservare integro il bagaglio consolidato delle culture e lingue di origine e della storia orale. Abbiamo così insistito affinché nel progetto DiMMI venisse introdotta la possibilità di scrivere storie e registrare racconti non solo in lingua italiana, che delle storie presentate al Concorso si conservassero sia le versioni originali che quelle tradotte (anche imperfettamente) in lingua italiana, e che queste storie “imperfette” venissero diffuse a largo raggio per stimolare una maggiore consapevolezza della ricchezza e della creatività dell’agire umano nelle società mobili e ibride di oggi.
Questi racconti sono le uniche voci che ci parlano direttamente, a distanza di ottanta anni dalle prime indipendenze dell’Africa, dall’interno del continente. Non ci sono più giornalisti o inviati nelle capitali e ancora meno nelle periferie del mondo cosiddetto in via di sviluppo, non c’è più quello che tra gli anni ‘60 e ’80 erano i Peace Corps che sono stati fonte di informazione straordinaria sulle geografie umane del mondo e non solo del continente africano. Le voci dei migranti sono le uniche capaci di testimoniare l’estrema varietà e difficoltà di vita nelle diverse regioni del mondo; sono loro, i migranti, i reporter informali e inascoltati di questo inizio secolo. Sono loro che ci possono informare delle reali ingiustizie sul terreno, delle difficoltà che vive una famiglia media africana, di cosa significhi appartenere a due religioni differenti, cosa vuol dire essere figlio di una madre con più padri o con famiglie disgregate, o come si sopravvive all’interno di contesti sociali, culturali o abitativi di scarsità, di conflitti o di emarginazione ai limiti dell’umano. Solo loro ci possono spiegare questa nuova ansia di futuro che la cecità dell’Europa di oggi non riesce a percepire e che cerca di combattere con muri, divieti, esternalizzazione, respingimenti. Una maggiore attenzione a quello che sta succedendo nel mondo di oggi porterebbe ad una diversa consapevolezza. E solo la diversa consapevolezza di quello che succede oggi nel mondo può forse portare a un sistema di leggi meno letali, che vede non più respingere gente che muore in mare, nel deserto o soffrire forme di sfruttamento a causa di nostre politiche di chiusura e di egoismi nazionali. La storia orale è una storia che ancora ci può raccontare e rendere più consapevoli di che cosa sia “la melanconia” dello stare nel mondo di oggi (Ortese) e cosa sia la tristezza del vivere in un mondo che non sembra voler imparare, ma solo incrementare, le sue politiche di profitto, di negazione dei diritti degli altri, e di sostanziale ostacolo alle aspettative pur generalizzate che provengono dai racconti e dalle storie di vita a tutti i livelli. La storia orale, se portata avanti in campi anche oltre quelli in cui è tradizionalmente nata, ha in sè una capacità rivoluzionaria di trasmettere nuove conoscenze e consapevolezze nel mondo.
GIULIA: Su questo. Come sai io ho scelto la storia orale come percorso di ricerca per il mio dottorato. E dopo Londra ho iniziato a chiedermi come in un contesto come quello dell’accademia neoliberale, che fa un uso sempre più strumentale (se non parassitario, neocoloniale) delle persone, delle soggettività migranti, delle storie, si possa ancora usare l’intervista.
ALESSANDRO: L’intervista ha una serie di limitazioni interne contro cui uno deve continuamente combattere e di cui si deve essere consapevoli. Innanzitutto, l’intervista non è l’inizio ma il risultato di una relazione. Occorre prima porre in essere il “patto di fiducia” tra chi intervista e chi è intervistato, e capire che l’intervista in quanto tale non ha senso se non all’interno di uno stare insieme, un parlare di cose che riguardano un terreno comune, un esplorare un modo di porsi di fronte alle molte asimmetrie che ci dividono gli uni dagli altri. Nei laboratori di auto-narrazione è bene partire non da una serie di domande ma da una tazza di tè, come scrive Svetlana Aleksievič e da una forma di intimità che possa innescare un processo di narrazione reciproca. Il raccontare-raccontarsi può aiutare il frame di una intervista là dove c’è scambio e circolarità di esperienze narrative. Questo vale anche nei laboratori di auto-narrazione che si fanno in molte scuole italiane. È la maestra per prima che deve dire da dove viene, o quale tram ha preso per arrivare a scuola, per avviare un riconoscimento delle molte diversità che ormai convivono nelle nostre classi; è ovviamente lei che deve stimolare i suoi alunni a raccontare i vari contesti di provenienza, sviluppando curiosità e domande sui luoghi di origine e sul racconto di sé come incontro dell’altro. Questi luoghi di origine, e di mobilità, possono essere anche dalla Calabria a Roma, non riguardare soltanto chi viene dal Mali e sbarca a Lampedusa. Allora, l’intervista oggi ha certo i suoi limiti ed è continuamente inficiata dalle mille false interviste che uno vede in televisione con domande aggressive e spiazzanti che chiaramente non vogliono altro se non lo sfruttamento della capacità narrativa altrui. Ormai si può chiedere e dire di tutto e qualsiasi risposta passa nel tritatutto dei social senza più moderazione o senso del pudore rispetto a quello che si può esprimere in pubblico. Da questo punto di vista, l’intervista di storia orale pur con i suoi limiti è un modo di comunicare e di cercare di entrare in sintonia con l’altro. Bourdieu insiste molto sul fatto che l’intervista è un incontro a due, una relazione con un gruppo, una forma di intermediazione tra due o più persone; e questa relazione tra persone deve essere mediata da una serie di piccoli accorgimenti, di graduali avvicinamenti, che devono avvenire prima dell’atto formale della narrazione e che sono indispensabili per “bonificare” quel terreno di mezzo spesso minato che si crea tra intervistatore e intervistato, l’asimmetria tra chi parla e chi ascolta e delle loro diverse condizioni di vita. Saper bonificare o più spesso lenire questo difficile terreno di mezzo è la sfida dell’oggi per tutti noi che lavoriamo in questo campo.
